Nel campo della genetica dell’epilessia e delle malformazioni della corteccia cerebrale è considerato un pioniere e un punto di riferimento internazionale. Parliamo del Professor Renzo Guerrini, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Meyer e Professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile all’Università di Firenze. In meno di due anni Lancet Neurology ha dedicato a Guerrini e a suoi studi due copertine, confermando l’importanza del suo lavoro che corre a metà tra ricerca e clinica. Guerrini, da anni impegnato a individuare e classificare nuove forme di epilessia e sindromi epilettiche nel bambino, caratterizzandone le basi genetiche, è non a caso il coordinatore di un grosso progetto dell’Unione Europea, “Desire” - 12 milioni di euro di finanziamenti, 25 partner di 11 Paesi, oltre 250 ricercatori in 19 Centri interessati dalla sperimentazione di base e clinica - che mira ad aprire nuovi scenari diagnostici e terapeutici in materia di epilessia nel bambino. Nuovi brillanti risultati non si sono fatti attendere: a 22 anni di distanza dall’aver descritto la sindrome perisilviana congenita, il gruppo di ricerca di Neurologia diretto e coordinato dal professore Guerrini ne ha identificato il gene responsabile, il PIK3R2. La nostra intervista comincia da qui.
Professore, come siete riusciti a individuare il gene responsabile della sindrome perisilviana congenita?
Come partner del progetto europeo “Desire” – che sta per ‘Development and Epilepsy - Strategies for Innovative Research to improve diagnosis, prevention and treatment in children with difficult to treat Epilepsy’ - abbiamo potuto eseguire studi molto costosi di sequenziamento esomico, da cui è emerso che vari individui con lo stesso fenotipo, una sindrome neurologica congenita causata da una malformazione della corteccia cerebrale delle regioni perisilviane del cervello, presentavano la stessa mutazione in mosaico (in circa il 20% delle cellule del sangue periferico e della saliva studiate e, verosimilmente, in analoga proporzione nelle cellule cerebrali). Questi studi di genetica avanzata sono stati condotti da un provider francese - purtroppo in Italia siamo molto indietro e questo ci costringe a rivolgerci all’estero per servizi di questo tipo. Individuato il dato che correlava il gene alla sindrome, abbiamo poi verificato la presenza di mutazioni dello stesso gene in una coorte molto più ampia di pazienti con la stessa malformazione, in collaborazione con il Seattle Children's Research Institute. Ciò ha permesso di fornire un quadro più completo dell’aspetto fenotipico correlando la percentuale di mutazione delle cellule con la gravità delle relative conseguenze sui pazienti.
Quali saranno le principali implicazioni di questa scoperta in ambito diagnostico e terapeutico?
Le implicazioni più immediate sono di tipo diagnostico e sono importanti perché, sebbene la sindrome perisilviana sia geneticamente eterogenea, aver identificato il gene che la causa in almeno una parte dei piccoli pazienti, ci permette di fornire una consulenza genetica alle loro famiglie, informandole sul rischio di ricorrenza della patologia nelle generazioni successive. Una possibilità di trasmissione ereditaria che in caso di mosaicismo nel paziente è nulla per i genitori che vogliono avere altri figli, e che è proporzionale alla percentuale di mosaicismo, ovvero di cellule dell’organismo e quindi anche riproduttive coinvolte, per gli individui affetti.
Quanto la vostra scoperta ci avvicina a un approccio terapeutico personalizzato?
La medicina di precisione è un’ipotesi che è sullo sfondo per le patologie malformative, ma è molto importante perché oggi altre condizioni con mutazioni di geni che appartengono alla stessa via biologica (via mTOR) sono già trattate con farmaci che ne migliorano le manifestazioni cliniche. La sclerosi tuberosa, per esempio, in cui l’elemento caratterizzante è la proliferazione di cellule spesso atipiche in vari tessuti, determina la crescita di tumori benigni, ma in posizioni tali da produrre conseguenze gravi sulla fisiologia del cervello. Trattati con farmaci questi tumori si riducono di dimensioni, si atrofizzano. E questo è già nella pratica clinica. Si sa, quindi, che le cellule che hanno uno sviluppo anormale, con una proliferazione eccessiva, sono sensibili a farmaci che inibiscono la proliferazione. In questo senso, è possibile ipotizzare che in un futuro non remoto sia possibile, attuando un trattamento precoce con questo tipo di farmaci, ridurre alcune delle conseguenze più gravi delle mutazioni genetiche.
Lei ha affermato che la vostra filosofia di lavoro è quella di fare ricerca scientifica in ambiti che hanno una ricaduta clinica molto forte e diretta. Dove vi sta portando questo approccio in altri filoni di ricerca?
Il progetto europeo di cui siamo partner ha come tema l’epilessia grave del bambino come conseguenza di uno sviluppo alterato del sistema nervoso. In questo ambito molto rilevante, basti pensare che il 40% dei nostri ricoveri riguarda bambini con questo tipo di patologie, purtroppo i risultati ottenuti dalle terapie farmacologiche sono deludenti. Il nostro impegno si concentra dunque su due filoni: la prevenzione da una parte, continuando ad approfondire le cause genetiche delle anomalie dello sviluppo cerebrale che causano epilessia, ma anche ritardo mentale, disturbi motori e autismo, e le cure risolutive dall’altra. Per l’epilessia, per esempio, una cura risolutiva può essere la chirurgia quando possiamo intervenire su una regione ristretta del cervello che è malformata e quindi produce attività epilettica, ma non è funzionante.
Studi come quello pubblicato su Lancet Neurology sono stati possibili grazie a collaborazioni multidisciplinari interne al Meyer ma anche esterne, dal Seattle Children's Research Institute alla Fondazione Imago 7 di Pisa. L’approccio multidisciplinare sembra quindi la chiave per affrontare e risolvere le sfide scientifiche. Ce lo può confermare?
Per risponderle deve fare un passo indietro e chiarire un aspetto a mio avviso fondamentale. Ci deve essere comunicazione e compenetrazione tra i vari anelli della ricerca, altrimenti si sprecano tempo e risorse. Faccio un esempio: se andiamo a descrivere una sindrome e ne caratterizziamo le cause genetiche, dobbiamo assicurarci che tutti i livelli di approfondimento siano adeguati, offrendo alla comunità scientifica ogni elemento utile a distinguerla da altre condizioni simili. Lo sforzo del nostro gruppo di ricerca va senz’altro in questa direzione e le collaborazioni cui ha fatto cenno sono un esempio di realtà che si possono associare per dare contributi complementari in grado di garantire approfondimenti di livello adeguato non solo limitatamente a un aspetto del problema.
Per “mancata compenetrazione tra i vari anelli della ricerca” cosa intende?
Tanti studi di genetica, anche molti avanzati, nascono in laboratori che sono avulsi dalla clinica e il risultato è che chi è al di fuori dallo studio spesso non capisce esattamente cosa abbiano i pazienti, quale sia la loro patologia, la storia della loro malattia e quindi a quali pazienti fra quelli che segue si estendano i nuovi dati. Ora non basta più associare un gene a un fenotipo in modo aneddotico, perché è ben dimostrato che mutazioni diverse di uno stesso gene possono avere conseguenze molto diverse e che, viceversa, uno stesso quadro clinico può essere causato da mutazioni di geni diversi. Poiché stiamo parlando di malattie che restano singolarmente rare, è solo mediante sforzi collaborativi di più centri, con expertise diverse, che si possono ottenere risultati utili in tempi ragionevoli. E’ in atto a più







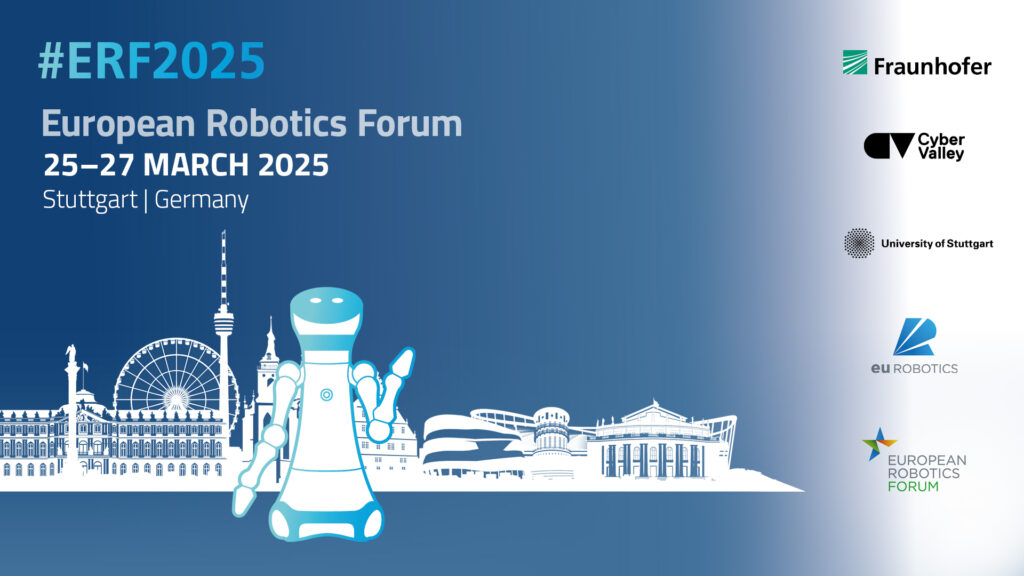

Lascia un commento